[Questa è la seconda parte dell’articolo; la prima parte può leggersi qui.]
 Il fine d’uno studio del genere non è, mi preme ripeterlo perché non vorrei esser frainteso, andare a far la spesa in latino o trattare il latino come qualsiasi lingua viva, magari l’inglese, che molti imparano per prender l’aereo e prenotare l’albergo, certo non per leggere Shakespeare, ma rivendicare al latino la sua natura di lingua come sopra descritta, che è stata troppo a lungo negata in favore d’uno studio della lingua scritta inteso, in ultima istanza, come studio della grammatica, a discapito del lessico, della pronunzia e in generale dell’organicità della lingua (sui limiti del cosiddetto metodo tradizionale, ma anche sui pericoli insiti in un approccio spericolatamente attivo, diremo qualcosa tra poco).
Il fine d’uno studio del genere non è, mi preme ripeterlo perché non vorrei esser frainteso, andare a far la spesa in latino o trattare il latino come qualsiasi lingua viva, magari l’inglese, che molti imparano per prender l’aereo e prenotare l’albergo, certo non per leggere Shakespeare, ma rivendicare al latino la sua natura di lingua come sopra descritta, che è stata troppo a lungo negata in favore d’uno studio della lingua scritta inteso, in ultima istanza, come studio della grammatica, a discapito del lessico, della pronunzia e in generale dell’organicità della lingua (sui limiti del cosiddetto metodo tradizionale, ma anche sui pericoli insiti in un approccio spericolatamente attivo, diremo qualcosa tra poco).
Una volta appurato che nell’insegnamento l’uso della lingua insegnata non solo non fa male e non è un gioco, ma è qualcosa d’estremamente serio e – almeno all’inizio, non tanto per gli studenti, quanto per gl’insegnanti non abituati – anche piuttosto faticoso, mi sembra che il punto sia d’avvalersi d’un metodo rigoroso e efficace, che ci conduca là dove vogliamo arrivare. Personalmente non credo alle scorciatoie, non credo cioè che l’uso di per sé consenta d’imparar bene – cioè a un livello tale da poter intendere un classico – una lingua, qualsiasi lingua, senza lo studio constante, attento e disciplinato; e non credo nemmeno che uno studio eccessivamente analitico, quasi meccanico e un po’ astratto, possa condurre, per quanto ordinato, all’apprendimento profondo d’una lingua senza un certo uso, orale e scritto.
Il metodo diretto, o naturale, escogitato dal Rouse, è stato successivamente affinato da H. H. Ørberg, autore di Lingua latina per se illustrata, che definì il suo metodo ‘natura’, o induttivo-contestuale, proprio per distinguerlo e per precisare ulteriormente come, seguendo la natura della lingua, si possa arrivare più speditamente alla lettura e alla comprensione dei classici. Le caratteristiche del metodo sono:
– centralità dell’aspetto orale (e quindi anche della pronunzia), pur senza negare l’importanza della scrittura;
– associare i suoni della lingua insegnata alle cose che essi rappresentano, senza passare, almeno all’inizio, attraverso la traduzione;
– presentazione della lingua all’interno di contesti e situazioni realistiche;
– apprendimento coinvolgente attraverso l’uso dei sensi e della fantasia, stimolando la curiosità e gl’interessi dei discenti;
– metodo induttivo: dall’osservazione d’usi sapientemente ripetuti all’interno d’un contesto alla formulazione d’una regola o all’apprendimento di parole e locuzioni, ecc.;
– accorta gradualità dell’insegnamento linguistico (dal più importante al meno importante, dal più al meno frequente, ecc.), ma senza rinunziare a nessuna delle parti che costituiscono una lingua (grammatica, lessico, stilistica, metrica, ecc.).
In pratica, soprattutto l’insegnante non avvezzo all’uso della lingua può strutturare la lezione in questo modo:
– attraverso singole immagini appositamente preparate e altre immagini tra loro collegate fino a formare una sorta di storia o di narrazione, introduzione delle parole nuove e, nella misura del possibile e delle capacità d’ognuno, della grammatica;
– domande orali per verificare la comprensione di quanto detto;
– lettura sensata (aderente al significato e alla situazione) da parte del docente, chiara nell’articolazione e nella pronunzia (le parole vanno raggruppate in gruppi di senso), e riflessione induttiva guidata (osservazione delle immagini presenti nel testo, delle note marginali, dei fenomeni grammaticali);
– domande continue durante la lettura del capitolo per verificare la comprensione del testo e per far usare grammatica e lessico;
– finito il capitolo, si ordinano sistematicamente i dati grammaticali, induttivamente appresi e già messi in pratica colle domande fatte dall’insegnante;
– numerosi esercizi di vario genere.
Una proposta del genere non è affatto meno seria, semplicistica, o più artificiosa rispetto al cosiddetto metodo tradizionale, sia perché richiede uno studio intenso, in cui l’allievo sia completamente coinvolto – giacché ascolta, parla, legge e scrive –, sia perché la lingua è considerata nella sua totalità, senza che nulla sia tralasciato, ma tutto è dosato secondo un criterio di gradualità che, per quanto diverso rispetto a quello tradizionale, non è affatto meno valido.
Se dunque il metodo natura, proprio in quanto tale, s’avvicina più d’ogni altro all’ideale percorso d’apprendimento che abbiamo tracciato, non per questo è privo di pericoli, insiti innanzitutto in un suo uso errato. Si badi bene, parlo d’un metodo, non d’un libro o del semplice uso del latino, che potrebb’essere discutibile, e sicuramente inefficace, se non incardinato in un metodo, appunto, che conduca il discente dal punto A, per così dire, al punto B, secondo modi precisi e tempi ragionevoli. Pertanto pregherei il lettore d’avvalersi d’una certa sottigliezza, e di non confondere tutti coloro che usano il latino coi sostenitori del metodo da me descritto, che anzi ne sono spesso i negatori, in quanto alcuni di loro giungono a teorizzare che il latino sia una lingua viva a tutti gli effetti.
Nei tanti corsi d’aggiornamento tenuti in Italia e all’estero, mi sono spesso imbattuto in tre tipi di docenti: gli entusiasti, che in quanto tali talvolta dall’uso giungono all’abuso del latino, servendosene in maniera non sempre appropriata e corretta; gli scettici, che rimproverano l’uso del latino, e così una tradizione millenaria, dicendo ch’è una cosa poca seria, ma in questo modo danno l’impressione di far di tutta l’erba un fascio, e di non entrare nel merito della questione, che non è riducibile al solo uso del latino; i dubbiosi incuriositi, coloro che hanno toccato con mano i limiti del metodo cosiddetto tradizionale, e vorrebbero cambiare (pur non confessandolo sempre a voce alta), ma hanno paura, perché dovrebbero modificare abitudini inveterate, e ormai non hanno più il tempo, e a volte nemmeno le forze, per imparare non solo un nuovo modo di far lezione, ma un nuovo modo di pensare il latino. In base alla mia esperienza, certamente limitata, ma comunque significativa, quest’ultima categoria è la più numerosa. Se infatti le cose funzionassero, se il metodo grammaticale-traduttivo, il più diffuso, fosse veramente efficace, non avremmo tanta emorragia di studenti (dovuta anche, ovviamente, a altre cause), i ragazzi non farebbero a gara a buttar via i libri di latino, e non avremmo bisogno d’intraprendere iniziative, come le notti bianche, divenute a quanto pare ormai necessarie per attirare i giovani allo studio delle lingue classiche.
Che le cose a scuola non vadano bene, ma non da oggi!, mi sembra un fatto innegabile. Che molti docenti cerchino d’inventarsi qualcosa di nuovo per incuriosire i ragazzi, mi sembra altrettanto innegabile. Che infine un numero crescente, seppur ancora ridotto, d’insegnanti prenda in considerazione l’uso della lingua, magari a livello ludico, per suscitare l’interesse degli allievi, è altresì innegabile.
Che fare, dunque? Premesso che ad impossibilia nemo tenetur, e che, se non dispone d’un numero sufficiente d’ore, anche il miglior insegnante farà fatica a fare il suo lavoro, bisognerebbe innanzitutto liberarsi dei pregiudizi, che sono tutti gli aggettivi parziali o inappropriati che accostiamo al latino, come abbiamo detto all’inizio, e che non ci consentono di vederlo per ciò che è: una lingua, se vogliamo storica e di cultura, ma innanzitutto una lingua. Se ce ne convincessimo, riusciremmo a vedere con facilità i rischi insiti nel metodo natura, o induttivo-contestuale, e i limiti del cosiddetto metodo tradizionale, cioè quello grammaticale-traduttivo, e conseguentemente a migliorare il nostro insegnamento.
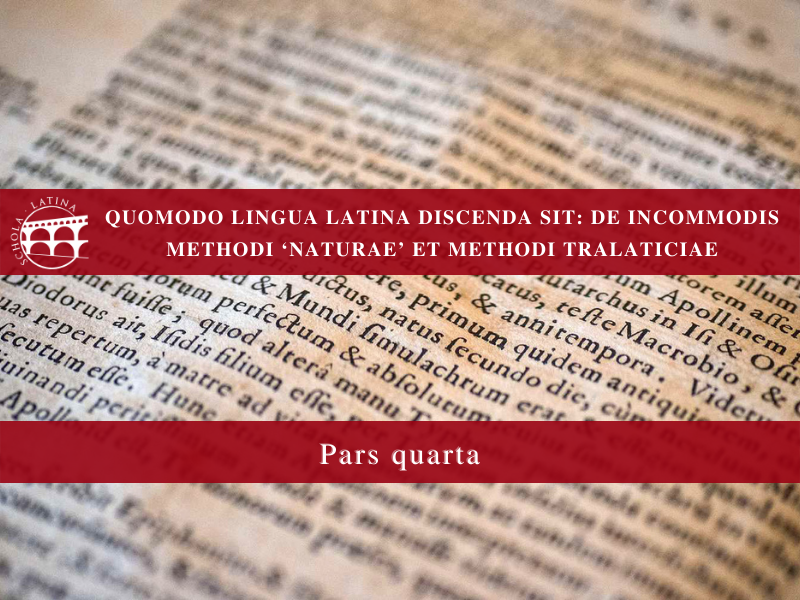 Ma vediamoli un po’, questi pericoli del metodo natura:
Ma vediamoli un po’, questi pericoli del metodo natura:
– eccessiva fiducia nell’uso della lingua e apprendimento un po’ superficiale, a orecchio, per così dire, a discapito d’uno studio analitico, comunque necessario per aver piena consapevolezza dei fenomeni linguistici che si studiano;
– uso improprio della lingua da parte dei docenti, che di solito non ricevono un’adeguata formazione: sbagliando loro, sbaglieranno di conseguenza anche i ragazzi. In realtà, non è il latine loqui di per sé biasimevole, ma il latine prave loqui. È forse meno vero per qualunque altra lingua?;
– errata applicazione del metodo: l’insegnante decide d’usare il metodo natura, ma poi in classe fa grosso modo ciò che faceva usando il metodo grammaticale-traduttivo, o comunque qualcosa di così ibrido da sconvolgere i princìpi sopra enunciati. Si tratta d’un errore molto frequente, anche perché non è obiettivamente facile per un docente abbandonare ciò a cui è abituato da tanto tempo per far qualcosa di nuovo.
E potremmo forse aggiungere altre due obiezioni, che di tanto in tanto si sentono in giro.
La prima: i testi sono spesso costruiti, nel senso che non sono classici, e pertanto non sono scritti in vero latino. Premesso che a me non sembrano affatto più costruiti di tante frasette che si trovano nei libri redatti secondo il metodo grammaticale-traduttivo, e che anche il concetto di vero latino andrebbe meglio precisato (è solo quello di Cesare e Cicerone, o accoglie, per dire, anche Plauto e Agostino?), chi di noi pretenderebbe di condurre gli studenti alla lettura di Dante, o di Shakespeare, mettendogli davanti frasi d’autore? E questo dopo che hanno studiato l’italiano, ma ormai anche l’inglese, per almeno dieci anni! Mi si dirà che sono lingue vive. E allora? Non è che uno possa intendere Dante sic et simpliciter, solo in quanto italiano. Si richiede studio, diligenza, tempo, perché Dante e Shakespeare, come Virgilio, sono classici, sono cioè un punto d’arrivo dello studio, non di partenza. E quindi, a ben vedere, non potrebbero non esser costruiti i testi con cui si comincia lo studio della lingua, ma costruiti non significa affatto falsi: l’importante è che siano corretti dal punto di vista grammaticale, appropriati dal punto di vista lessicale, graduali e funzionali.
La seconda: chi usa il metodo natura non sa tradurre. Anche qui, mi sembra che si confonda l’errato uso del metodo col metodo, e, più in generale, la traduzione colla conoscenza della lingua, come se il fine dello studio fosse saper tradurre, quando invece questo non è altro che la conseguenza della conoscenza della lingua, non solo latina, dalla quale si traduce, ma anche materna, nella quale si traduce. Si traduca, dunque, purché si faccia non per comprendere, ma dopo aver compreso. L’unica avvertenza, per altro molto ragionevole, è che non si traduca sùbito: prima immergiamo il ragazzo nella lingua: ascolti, parli, legga, scriva (in latino!) e, dopo aver formalizzato i concetti appresi, traduca pure. Magari all’inizio si potrà un po’ soprassedere, sia perché molte cose sono simili all’italiano sia per non frenare l’apprendimento coll’analisi eccessiva, ma si traduca, ripeto, avendo però cura di proporre agli studenti testi proporzionati alle loro conoscenze, e non testi troppo onerosi per spalle non ancora robuste.
Tralascio altre cose, che pure ho sentito, e che mi sembrano confermare una mia convinzione, che cioè molti confondano il metodo natura, in verità estremamente rigoroso, con un vago uso del latino che non preveda lo studio della grammatica. Si può forse apprendere una lingua, per altro non viva, senza studiare la grammatica? Assolutamente no. Se parlo e scrivo in latino, allora ipso facto uso il metodo natura? Assolutamente no. Ma chi fa queste associazioni o è in mala fede, o per lo meno pecca di superficialità.
Dopo tanti anni direi che sono nel complesso appurati, sempre ammesso che non si abbiano pregiudizi, anche i limiti del cosiddetto metodo tradizionale:
– mancanza del collegamento intimo tra parole e cose, fondamentale in ogni apprendimento linguistico. Gli studenti non collegano i suoni della lingua a ciò ch’essi significano, ma collegano la parola scritta al suo equivalente nella lingua materna: invece di collegare la parola mensa all’immagine mentale della tavola, per lo più collegano la parola mensa alla corrispondente parola italiana, e ne consegue che spesso debbano tradurre per capire;
– scarso apprendimento del lessico, anche perché studiato senza il sostegno mnemonico d’un contesto significativo, ma con frasi alquanto improbabili e per lo più sconnesse tra di loro: le famigerate Rosarum et violarum coronas ancillae portant, o Nimia aviarum indulgentia puellis nocet, e chi più ne ha più ne metta;
– studio piuttosto astratto e meccanico della grammatica: gli studenti sanno spesso dire cose sulla lingua, la sanno grosso modo descrivere, ma non sanno la lingua, se dopo anni di studio anche i migliori fanno fatica a comprendere dieci righe col vocabolario. Insomma, l’analisi non basta.
Dal ragionamento fin qui fatto mi sembra che si possa pacificamente concludere che spesso a scuola si fa confusione tra due concetti collegati, ma pur sempre diversi: conoscenza della lingua e conoscenze sulla lingua. Il metodo grammaticale-traduttivo tende a descrivere la lingua, a fornire cioè agli studenti una serie di conoscenze sulla lingua, trascurando la conoscenza della lingua, che invece è il fuoco del metodo natura, o induttivo-contestuale, che a sua volta rischia però d’omettere aspetti analitici fondamentali per la conoscenza sulla lingua, se malamente inteso o applicato.
Insomma, l’ideale sarebbe unum facere et aliud non omittere, per comprendere appieno un classico in lingua originale. Perché la questione di fondo è poi questa: perché leggerli in latino? Quei pochi scrittori che si leggono o, per meglio dire, s’interpretano a scuola sono stati già più volte tradotti; perché dunque affaticarsi tanto a imparare il latino? A questa domanda ho dato una mia personale risposta in un’altra occasione; quel che ora mi preme sottolineare è che non è, e non potrà mai essere, lo stesso leggere un classico in latino e in traduzione. E questo non per i demeriti eventuali del traduttore, ma perché un classico, proprio in quanto tale, è un’opera d’arte, e in ogni arte ci sono aspetti intraducibili. O forse è la stessa cosa osservare la Pietà di Michelangelo e una sua foto? ascoltare dal vivo un’esecuzione musicale o una sua registrazione?
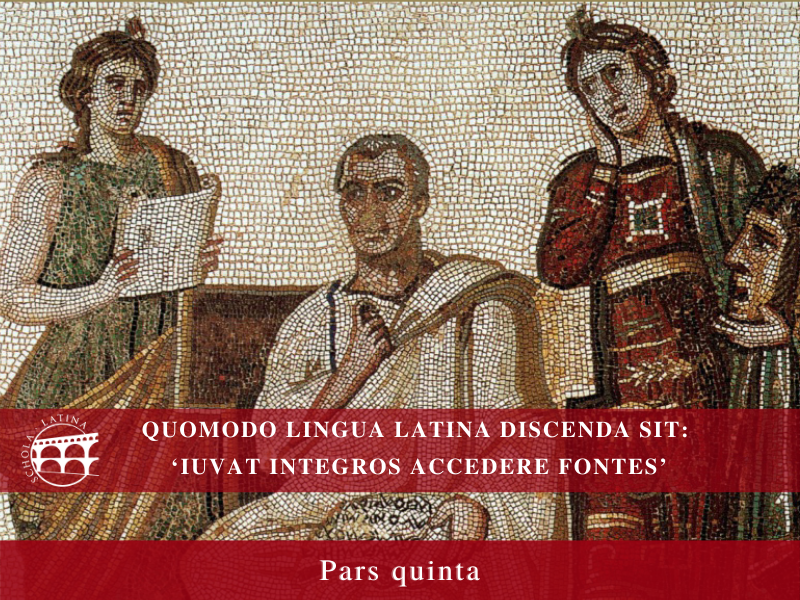 Se dunque l’arte di Michelangelo è in quel suo preciso modo di scolpire, l’arte d’uno scrittore, prosatore o poeta che sia, è in quel preciso modo di scrivere, che lo distingue da tutti gli altri. Prendiamo per esempio Sallustio, contemporaneo di Cicerone e Cesare, come tutti sanno. Prendiamo l’incipit notissimo della congiura di Catilina (i neretti sono, ovviamente, miei):
Se dunque l’arte di Michelangelo è in quel suo preciso modo di scolpire, l’arte d’uno scrittore, prosatore o poeta che sia, è in quel preciso modo di scrivere, che lo distingue da tutti gli altri. Prendiamo per esempio Sallustio, contemporaneo di Cicerone e Cesare, come tutti sanno. Prendiamo l’incipit notissimo della congiura di Catilina (i neretti sono, ovviamente, miei):
[1] Omnis homines, qui sese student praestare ceteris animalibus, summa ope niti decet, ne vitam silentio transeant veluti pecora, quae natura prona atque ventri oboedientia finxit. [2] Sed nostra omnis vis in animo et corpore sita est: animi imperio, corporis servitio magis utimur; alterum nobis cum dis, alterum cum beluis commune est. [3] Quo mihi rectius videtur ingeni quam virium opibus gloriam quaerere et, quoniam vita ipsa, qua fruimur, brevis est, memoriam nostri quam maxume longam efficere. [4] Nam divitiarum et formae gloria fluxa atque fragilis est, virtus clara aeternaque habetur.
Qui Sallustio espone un concetto per nulla originale, nel senso di personale, ma classico nel senso pieno della parola: il primato dell’anima sul corpo. Da Platone (si veda, a mo’ d’esempio, il Fedone, 28) a sant’Agostino è, come si sa, un concetto che attraversa tutta l’antichità greco-romana. Perché dunque merita d’esser letto e gustato in latino? Perché l’arte è proprio lì, nella lingua, nella scelta e nell’ordine delle parole, come fa notare nel suo bel commento la Malcovati (Enrica Malcovati, De Catilinae coniuratione, Paravia, Torino, 1939), da cui traggo molto di ciò che segue.
Cominciamo dall’omnis iniziale, che ha un chiaro colorito arcaico, per poi osservare quel sese, che, sebbene ben comprensibile, a un’analisi più attenta risulta superfluo, perché studere, al pari di velle, cupere e in genere dei verba voluntatis et studii, si costruisce col semplice infinito quando il soggetto è uguale nelle due proposizioni: anche in questo caso, in cui fra l’altro il pronome è raddoppiato, come a dargli più forza, si tratterebbe dunque d’un uso arcaico e popolare. La locuzione vitam transire, per quanto, direi, d’immediata comprensione, in verità non è affatto comune, perché di solito si diceva vitam agere, o ducere, ma Sallustio – lo vediamo già in questa prima riga – non ama le espressioni comuni. In ‘oboedientia finxit’ troviamo invece la cosiddetta clausola eroica (fine d’esametro: dattilo e spondeo), ch’è volutamente evitata da Cicerone, memore dell’insegnamento d’Aristotele (qui iudicat heroum numerum grandiorem quam desideret soluta oratio, “Orator”, 192); ma Sallustio ha un gusto diverso dall’Arpinate. Il sed, poi, non ha il consueto valore avversativo, ma serve qui di trapasso, e corrisponde a ‘ora’, come già Servio aveva notato (ad Aen. X, 411: ‘sed’ modo inceptiva particula est, ut in Sallustio saepius). Si noti poi la collocazione di nostra: Sallustio non dice omnis vis nostra, come sarebbe più naturale, ma pone nostra all’inizio per accentuare il contrasto tra noi, uomini, e le fiere, a noi contrapposte. Come si sa, il latino, soprattutto arcaico, non amava le parole e le espressioni astratte, ma Sallustio si scosta da questa consuetudine, per seguire una tendenza che andrà crescendo dall’età d’Augusto in poi: dice dunque animi imperio e corporis servitio, invece di animo imperatore e corpore servo (cfr. “Bellum iugurthinum”, I, 3: dux atque imperator vitae mortalium animus est). A prima vista l’ipsa seguente sembrerebbe superfluo: perché non dire semplicemente vita qua fruimur brevis est? Ma ipsa ha il suo consueto valore d’opposizione, come in espressioni quali ipso die (‘quello stesso giorno, e non un altro’), e qui vita è contrapposta a memoria nostri. In maxume troviamo il suffisso –umus del superlativo, che in Sallusto non è mai -imus: un altro arcaismo. In fluxa atque fragilis notiamo la consonanza iniziale, ch’è un elemento arcaico grato a Sallustio (basti pensare alle antiche formule ritmiche dei romani: proverbi, preghiere, scongiuri, massime giuridiche). In virtus clara aeternaque habetur, infine, dove habetur non significa ‘è ritenuta’, ma ‘è posseduta, è in poter nostro’, sentiamo attraverso l’asindeto e la brevitas come la stabilità della virtù sia contrapposta per antitesi alla caducità di quella gloria divitiarum et formae, fluxa atque fragilis, che nella struttura stessa della frase, prolungata dalla congiunzione copulativa, ha qualcosa di liquido, di fuggevole.
Se dunque vogliamo sentire la vera voce dei classici, e non una pallida eco, non solo li dobbiamo leggere e comprendere in latino, ma dobbiamo essere in grado, coll’aiuto di guide e strumenti adeguati, di cogliere e gustare la loro arte. Nel nostro caso, è evidente come la lingua di Sallustio sia tutta sua, e sia ben diversa da quella di Cesare e di Cicerone, suoi contemporanei: è il suo marchio, cioè la sua arte. È l’immortalis Sallusti velocitas di cui parla Quintiliano (X, 112), è illa sallustiana brevitas, qua nihil apud aures vacuas atque eruditas potest esse perfectius (X, 32).
Roberto Carfagni







Scrivi un commento